
Il programma Sabbatini e lo spirito della Bocconi
di Carlo Secchi
*Rettore Universita' Bocconi di Milano
Ad un secolo di distanza dalla sua nascita, la celebre istituzione meneghina ricorda l'impegno e il ruolo di chi ha ispirato con la sua carica innovativa i valori che ancora oggi caratterizzazno e animano "la prima liberta' università" del nostro Paese
Con la giornata
bocconiana del 2001, Milano vede aprirsi il centesimo anno accademico
dell’Università Bocconi. Non è questa la sede per trattare
la storia secolare della nostra istituzione; esistono ottime storiografie
della prima libera università italiana, cui si rimanda1.
L’intento è invece di ripercorrere qui l’avventura intellettuale
ed etica che portò alla fondazione della Bocconi, di rivisitare
la matrice ideale che continua ad alimentare la spinta innovativa della
nostra università. Si intende insomma delineare i tratti salienti
di ciò che, per analogia spuria con Max Weber, possiamo definire
"lo spirito della Bocconi". Esercita infatti ancora forte richiamo, a
un secolo di distanza, la carica di innovazione che Leopoldo Sabbatini
– nostro primo presidente e rettore, nonché segretario della Camera
di Commercio di Milano – seppe infondere al progetto che istituiva la
prima università in Italia per lo studio delle discipline economiche
ed aziendali.
Il programma Sabbatini era talmente in anticipo sui tempi da servire da
modello a tutte le facoltà universitarie di economia che nei primi
decenni del XX secolo presero a sorgere in Italia sull’esempio dell’istituzione
fortemente voluta da Ferdinando Bocconi. Inizialmente Ferdinando intendeva
commemorare il figlio Luigi, scomparso ad Adua, con l’istituzione di una
Scuola Superiore di Commercio affiliata al Politecnico di Milano. Vi erano
allora in Italia tre Scuole Superiori di Commercio con sede a Venezia,
Genova e Bari. Diplomavano quadri intermedi per l’industria e il commercio
offrendo corsi biennali o triennali dal taglio eminentemente pratico,
in cui ragioneria e "banco modello" dominavano i curricula.
I sanguinosi eventi del 1898 spinsero Ferdinando ad accantonare il progetto
di una Bocconi inserita nel Politecnico. Dopo i cannoneggiamenti di Bava
Beccaris sulla folla di Milano, il circolo di industriali e accademici
di cui si era circondato dovette apparirgli troppo autoritario sulle questioni
sociali e al contempo troppo cedevole col protezionismo sulle questioni
economiche, per poter imprimere l’indirizzo pienamente liberaldemocratico
che desiderava all’impresa didattica in gestazione. Inoltre l’imprenditore
dei grandi magazzini Bocconi non condivideva l’impostazione di tipo eccessivamente
professionale del primo progetto: "D’accordo di bandire il dottrinarismo
(…). Ma si vivifichi l’insegnamento pratico con una coltura larga, coltura
positiva di tutto quanto ha rapporto alla via e alle manifestazioni economiche
dei popoli"2.
La nuova amministrazione di fede democratica, insediatasi alla fine del
1899 a Palazzo Marino, salutava con favore l’orientamento del commendator
Bocconi. Il progetto di una facoltà commerciale autonoma avveniva
sotto l’egida della Camera di Commercio di Milano. Oltre al segretario
Sabbatini, sarebbero entrati nel primo Consiglio direttivo della Bocconi
il suo presidente Angelo Salmoiraghi, il consigliere Cesare Mangili, che
andavano ad aggiungersi al membro di diritto nominato dalla Camera di
Commercio, il suo vicepresidente Carlo Vanzetti. Del vecchio gruppo del
Politecnico continuava a dare la sua collaborazione al progetto un industriale
d’eccezione, Giovanni Battista Pirelli, il fondatore della transnazionale
italiana.
Dopo le convulsioni politiche successive al 1898, Ferdinando Bocconi decise
quindi di rivolgersi per la progettazione della nuova università
a un innovatore, a un sincero progressista che appartenesse alla Milano
democratica e condividesse idealmente la politica illuminata che Zanardelli
e Giolitti stavano avviando: l’avvocato Leopoldo Sabbatini, appunto. Il
frutto dell’incontro fra un mecenate e un public intellectual è
il programma Sabbatini, lucida testimonianza della fede nel possibile
connubio fra pragmatismo dell’impresa e la scientificità degli
studi economici.
Nelle parole dell’ideatore della Bocconi, l’obiettivo precipuo della nuova
facoltà commerciale doveva essere "una scientifica conoscenza dei
fenomeni economici e delle leggi che li governano, una completa preparazione
dei giovani alla soluzione di tutti i più difficili e complessi
problemi della vita sociale". Secondo Sabbatini, tale conoscenza e preparazione
poteva essere perseguita solo mediante lo studio "di un complesso organico
di insegnamenti tutti preordinati al medesimo fine e larghi così
da abbracciare ogni manifestazione, ogni lato dell’attività economica"3.
Agli inizi del XX secolo il mondo era ancora aperto e libero, le comunicazioni
rapide, gli scambi intensi; l’avanzare della ragione e della democrazia
parevano un processo inarrestabile. Di fronte alla prima globalizzazione
economica che animava la belle époque liberale, era convincimento
di Sabbatini che l’investimento nella formazione e nell’educazione dei
giovani italiani si sarebbe rivelata la principale leva di crescita economica,
scientifica e civile per un Paese che voleva modernizzarsi e concorrere
con le altre nazioni illuminate all’intervento cosciente e progressivo
sulle vicende del mondo: "In questi ultimi anni è avvenuto un profondo
mutamento nelle condizioni generali dei Paesi civili. (…) Le relazioni
economiche tra popolo e popolo in tutto il mondo hanno acquistato tale
complessità, tale intensità che costituiscono un fenomeno
veramente nuovo e grandioso. La scuola deve seguire dappresso questo mutamento;
per rispondere ai propri fini deve soddisfare alle nuove necessità
della vita. (…) La vita economica odierna non è dato padroneggiarla
per sola esperienza personale o col sussidio soltanto di cognizioni professionali.
Per avere in essa parte effettiva, specialmente per concorrere con efficace
influenza al movimento internazionale, è oggi indispensabile essere
in grado di conoscere, di valutare, di interpretare le leggi che governano
il mondo economico. A questo risultato può giungere solo una cultura
strettamente scienti-fica"4.
Stilato nel 1901, il programma di Sabbatini attribuiva con decisione e
preveggenza lo statuto di scienza all’economia politica, la quale doveva
costituire il perno della formazione dei futuri dottori in scienze economiche
e commerciali (titolo di cui i primi bocconiani poterono fregiarsi a partire
dal 1906). Dobbiamo ricordare che quelli erano gli anni in cui le enunciazioni
teoriche degli studiosi italiani – figure del calibro di Maffeo Pantaleoni,
Vilfredo Pareto e dei suoi seguaci, il cosiddetto "paretaio", nonché
del giovane Luigi Einaudi – stavano rivoluzionando il modo di fare economia
in tutto il mondo, adottando una metodologia rigorosa in grado di farla
evolvere come scienza normativa capace di proposizioni empiricamente verificabili.
Nelle intenzioni del primo rettore e presidente della Bocconi, l’economia
doveva essere "l’insegnamento più importante", a cui doveva "essere
data la maggiore estensione e attribuito il maggior tempo"5.
L’esame del primo programma dei corsi della neonata Bocconi, tenutisi
nella prima sede di via Statuto, fornisce prova tangibile dei propositi
di Sabbatini, così come della sua capacità, assai rappresentativa
dello spirito della Bocconi, di compiere la transizione dalle audaci enunciazioni
di principio agli aspetti, anche minuti, della progettazione e realizzazione
di un’istituzione accademica. 6
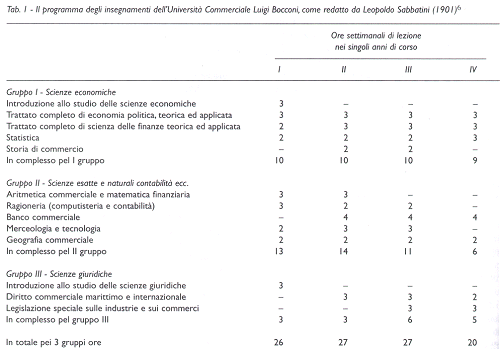
La preminenza degli studi economici è evidente dalla collocazione
gerarchica di Sabbatini, anche se alle discipline aziendali veniva accordata
una leggera preponderanza in termini quantitativi. Sull’arco dei quattro
anni, il ramo economico pesava per il 39 per cento sulle ore complessive
di lezione, mentre il ramo aziendale ammontava al 44 per cento del carico
didattico, con il ramo giuridico a coprire il restante 17 per cento. Questi
insegnamenti erano i "corsi generali" che tutti i bocconiani dovevano
affrontare; era altresì prevista – altra grande innovazione di
Sabbatini inedita per l’Italia – l’istituzione di "corsi speciali" scelti
dallo studente sulla base delle proprie inclinazioni riguardanti la carriera
futura oppure in svolgimento7.
La modernità delle scelte didattiche non potrà mancare di
colpire il lettore8.
Azzardando una metafora architettonica, se nei propositi di Sabbatini
l’economia è l’arco di volta della nuova università commerciale,
gli studi aziendali ne sono i pilastri e gli studi giuridici i capitelli.
È evidente che il progetto di Sabbatini mirava a un’istituzione
universitaria che potesse fondere al meglio ciò che gli
anglosassoni chiamano business administration con quello che definiscono
economics. Per chi conosce la storia delle menti che hanno fatto
crescere nei decenni il nostro Ateneo, si può dire che in embrione
c’era già la grande sintesi bocconiana personificata da Luigi Einaudi
da una parte e Gino Zappa dall’altra, i due giganti rispettivamente dell’economia
e della ragioneria italiane. Pratica e teoria, scuola e vita dovevano
entrambe nutrire la formazione del bocconiano, così da renderlo
in grado, per esempio, sia di riclassificare un bilancio di una grande
impresa, sia di applicare l’analisi macroeconomica alla performance
di una nazione.
Mi preme di notare che la sintesi disciplinare di Sabbatini ha dato vita
a un’istituzione pressoché unica al mondo per la contemporanea
eccellenza dei suoi dipartimenti di economia aziendale e di economia politica.
Certo, la London School of Economics dell’amico Dahrendorf eccelle
nell’economia e nelle scienze sociali, ma non nelle discipline aziendali.
Senza dubbio Harvard dispone di uno dei migliori dipartimenti di economia
al mondo, ma la sua omonima e antonomastica Business School è
a tutti gli effetti un’istituzione separata, tanto da dare vita a una
university press a sé stante. Mentre in Bocconi vige la
compenetrazione più stretta fra le discipline aziendali, economiche,
giuridiche, sociali e quantitative, frutto di un modello formativo integrato
che ha pochi rivali al mondo e che deve la sua ispirazione a Leopoldo
Sabbatini.
I valori dell’Università Bocconi: modernità, cosmopolitismo, scientificità, pragmatismo
I valori del programma Sabbatini
sono ancora attuali a un secolo di distanza. Sono valori di fiducia e
curiosità verso il nuovo che avanza e di confronto costante con
l’esperienza internazionale. L’Università Bocconi non è
mai venuta meno, anche durante il regime fascista, alla propria vocazione
europea e cosmopolita. La recente Convenzione della Sorbona con Francia,
Germania e Regno Unito fornisce finalmente le basi per la creazione di
un sistema universitario europeo. L’eccellenza della Bocconi si misurerà
da come i suoi programmi undergraduate, graduate o postgraduate
sapranno raccogliere la sfida del nuovo mercato accademico europeo, attirando
docenti e studenti da tutte le regioni dell’Unione. L’imperativo della
Bocconi è sempre stato contribuire al progresso materiale e politico
del Paese, aprendosi ai flussi di conoscenza che attraversano Milano e
l’Europa.
I valori che animano lo spirito Bocconi sono l’impegno a fornire una solida
e ampia formazione culturale a generazioni di studenti, attraverso standard
rigorosi di apprendimento e di ricerca applicati allo studio dell’economia
e delle imprese. Sono il contatto con la vita concreta e i suoi tempi
e problemi non rinviabili. Sono infine la missione di formare una classe
dirigente che all’eccellenza intellettuale e gestionale coniughi una caratura
morale ineccepibile.
Su tutto il sistema universitario italiano pesa la responsabilità
di trattenere nel nostro Paese i giovani talenti che la nostra insipienza
e la nostra miopia negli indirizzi della spesa pubblica fanno sì
che siano tentati di migrare all’estero, impoverendo il nostro tessuto
scientifico e la nostra vita intellettuale. Perché i giovani con
le migliori potenzialità, da qualunque classe sociale o provenienza
geografica, vengano attratti e incitati dalle nostre università,
dobbiamo essere in grado di dare vita nelle nostre metropoli a bacini
di capitale umano in cui università, imprese, istituzioni territoriali
e collettività urbane creino esternalità positive nella
ricerca, nella formazione, nella diffusione di saperi e tecniche a imprese
e individui.
Confido che le future generazioni di studiosi, amministratori e professionisti
che si formeranno in via Sarfatti incarneranno con ancor più determinazione
la validità delle tradizioni bocconiane di libertà e conoscenza.
Il capitale umano è la vera fonte della ricchezza delle nazioni.
Leopoldo Sabbatini l’aveva ben compreso molti anni prima che Gary Becker
ne fornisse una teoria compiuta.
Note
1.
Marco Cattini, Enrico Decleva, Aldo De Maddalena, Marzio A. Romani, Storia
di una libera università: l’Università Commerciale Luigi
Bocconi dalle origini al 1914, Milano, EGEA, 1992; Storia di una
libera università: l’Università Commerciale Luigi Bocconi
dal 1915 al 1945, Milano, EGEA, 1997. Per una survey della
nostra storia, si veda: Enrico Resti, L’Università Bocconi:
dalla fondazione a oggi, Milano, EGEA, 2000.
2.
Ferdinando Bocconi, "Per un Istituto Superiore di Commercio", L’industria,
XII, n. 25, 1898.
3.
Citato in Marco Cattini, Enrico Decleva, Aldo De Maddalena, Marzio A.
Romani, Storia di una libera università: l’Università
Commerciale Luigi Bocconi dalle origini al 1914, Milano, EGEA, 1992.
4.Programma
Sabbatini.
5..
Programma Sabbatini.
6.Programma
Sabbatini.
7.
In retrospettiva, appare tanto pionieristica l’enfasi sull’economia, quanto
misteriosa la ritrosia del nostro primo rettore nei confronti della scienza
del diritto, da cui egli pur proveniva (si era laureato in Legge a Pisa).
Si noti anche l’entità dell’impegno settimanale richiesto a studenti
e docenti. Con spirito tutto positivista, le ore complessive settimanali
di lezione nell’Ateneo sarebbero ammontate esattamente a 100.
8.
Come da minuta conservata nell’Archivio storico dell’Università
Bocconi.
